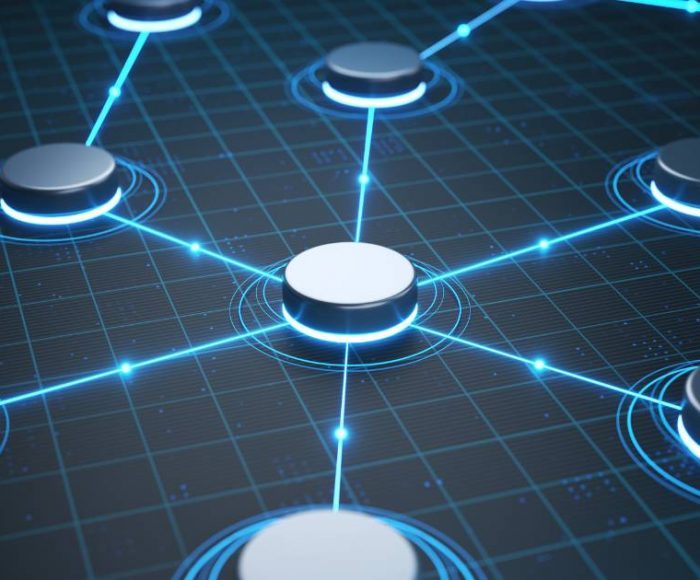Il mondo delle imprese ha ben chiaro oggi che la competitività esige la sostenibilità, intesa come processo realmente trasformativo e non come azione strumentale o adattiva.
Chi fa sul serio è in grado di dimostrare la convenienza di un modello di creazione del valore che quotidianamente si misura con un diverso concetto di “efficienza”, di “profittabilità”. Un modello che, per esternare positività, va declinato dentro tutta la catena del valore e non solo su alcune funzioni.
Orientare la sostenibilità verso lo sviluppo integrale non è solo una priorità delle policy ma un imperativo a cui sono chiamate tutte le istituzioni economiche.
Diversamente dal concetto di crescita, lo sviluppo sostenibile rappresenta un cambiamento verso il meglio, un cambiamento capace di generare un incremento di valore, inteso in misura “multi-dimensionale” e non come mero profitto.
La notizia è che l’impresa che massimizza la propria utilità non è detto che sia più competitiva, anzi le evidenze ci raccontano che l’orizzonte a cui un’impresa deve tendere per competere e prosperare è quello di massimizzare il valore condividendolo, in maniera autentica, con tutti gli stakeholder che hanno contribuito a generarlo. In altri termini, possiamo dire che la competizione passa per la “condivisione e co-creazione” del valore aggiunto.
È in questo surplus di valore che risiede la vera e propria ragion d’essere della sostenibilità.
Le imprese sostenibili non solo quelle che si «adattano» ai cambiamenti, riducendo gli effetti negativi in tema ambientale, ma quelle che oggi stanno investendo in nuovi modelli di business e che si danno obiettivi diversi dal passato: indicatori diversamente competitivi.
Un cambiamento guidato da uno scopo (purpose) e da declinarsi in maniera integrale: non basta infatti l’integrità delle metriche per costruire una prospettiva credibile di sostenibilità, serve una «integralità di prospettiva», una intenzionalità che va resa concreta tanto nel reporting, quanto nella governance.
Per questo motivo, oggi all’impresa non può bastare un set di indicatori ambientali (necessari) ma occorre dotarsi anche di una “misura” capace di perseguire benefici sociali; il punto di debolezza di molti strumenti di reporting legati alla sostenibilità risiede infatti nella timidezza con i quali vengono perseguiti e misurati gli obiettivi sociali.
Nonostante stia crescendo l’attenzione e la produzione di linee guida e nuovi regolamenti a livello internazionale (es. il Corporate Sustainability Reporting Directive che si propone di rafforzare le direttive contenute nel “non financial reporting”, il Sustainable Finance Disclosure Regulation sulla trasparenza delle informazioni relative alla finanza sostenibile e la Taxonomy Regulation che si propone di riclassificare le attività economiche eco-compatibili in termini di sostenibilità) prevale ancora un approccio orientato a non “recar danno” oppure ad una visione “adattiva”.
La spinta che le metriche “ESG” stanno dando al riorientamento dei flussi finanziari, dell’asset management e delle scelte dei risparmiatori sono rilevatissime e segnano un positivo e radicale cambio di prospettiva.
Una traiettoria irreversibile che può arrivare al cuore del sistema economico-finanziario oppure può rimanere in superficie. Un dilemma che si gioca in gran parte sulla capacità di declinare in misura radicale e coraggiosa la “S” del noto acronimo ESG, orientando così la misurazione verso l’impatto sociale. Occorre evitare che la componente “sociale” assuma una rilevanza strumentale rispetto a quella ambientale (E) e di governance (G): è una priorità ed una corresponsabilità di cui dobbiamo essere coscienti, se vogliamo realmente alimentare cambiamenti desiderati.